di Massimo Fini

L’Onu ha autorizzato i raid aerei sulla Libia. Francia e Gran Bretagna sono già pronte a far intervenire i loro caccia perché abbattano quelli di Gheddafi che bombardano i rivoltosi libici, e non è escluso che l’Italia metta a disposizione della Nato le sue basi aeree. Non è una dichiarazione di guerra alla Libia, non sia mai, oggi ci si vergogna di fare la guerra e si preferisce chiamarla “operazione di peace keeping” a difesa dei “diritti umani”.
Salta definitivamente il principio internazionale di “non ingerenza militare negli affari interni di uno Stato sovrano” insieme al diritto di autodeterminazione dei popoli sancito a Helsinki nel 1975 e sottoscritto da quasi tutti i Paesi del mondo, compresi quelli che stanno per intervenire in Libia. Qui siamo in una situazione diversa dagli interventi in Iraq nel 1990 e nel 2003 e in Afghanistan nel 2001. Nel primo conflitto del Golfo, l’Iraq aveva aggredito il Kuwait, uno Stato sovrano, sia pur fasullo creato nel 1960, esclusivamente per gli interessi petroliferi degli Stati Uniti. L’intervento quindi era legittimo, anche se il modo con cui fu condotta quella guerra fu bestiale perché gli americani, pur di non affrontare fin da subito, sul terreno, l’imbelle esercito iracheno (che era stato battuto perfino dai curdi, in quel caso Saddam fu salvato dalla Turchia il grande alleato Usa nella regione) e correre il rischio di perdere qualche soldato, bombardarono per tre mesi le principali città irachene facendo 160mila morti civili, fra cui 32.195 bambini (dati del Pentagono). Nel 2003 c’era il pretesto delle “armi di distruzione di massa”. Si scoprì poi che queste armi, che Stati Uniti, Urss e Francia gli avevano fornito, Saddam non le aveva più, ma intanto gli americani hanno ridotto l’Iraq a un loro protettorato dove è in corso una feroce guerra civile fra sciiti e sunniti che provoca decine e a volte centinaia di morti quasi ogni giorno tanto che in Occidente non se ne dà più notizia. In Afghanistan si voleva prendere Bin Laden, ma dopo dieci anni la Nato è ancora lì e occupa quel Paese, avendo provocato, direttamente o indirettamente, 60mila morti civili (e nessun Consiglio di sicurezza si è mai sognato di imporre una “no fly zone” ai caccia americani che, per battere gli insorti, bombardano a tappeto cittadine e villaggi facendo ogni volta decine di vittime civili, come sta facendo Gheddafi in Libia). La situazione è invece identica all’intervento Nato in Serbia dove, all’interno di uno Stato sovrano, c’era un conflitto fra Belgrado e gli indipendentisti albanesi, foraggiati dagli americani, del Kosovo che della Serbia faceva parte. Noi, che non abbiamo baciato la mano a Gheddafi, che non abbiamo permesso ai suoi cavalli berberi di esibirsi alla caserma Salvo d’Acquisto e al dittatore di volteggiare liberamente per Roma avendo al seguito 500 troie, e che parteggiamo per i rivoltosi di Bengasi, siamo assolutamente contrari a qualsiasi intervento armato in Libia. Per ragioni di principio e perché questi interventi internazionali sono del tutto arbitrari. Dividono gli Stati in figli e figliastri. Nessuno ha mai proposto una “no fly zone” in Cecenia dove le armate russe di Eltsin e dell’ “amico Putin” hanno consumato il più grande genocidio dell’era moderna: 250 mila morti su una popolazione di un milione. Nessuno si sogna di intervenire in Tibet (chi si metterebbe mai, oggi, contro la succulenta Cina?) o in Birmania a favore dei Karen. E così via. In ogni caso bisogna essere consapevoli delle conseguenze delle proprie azioni. Se l’Italia presterà le proprie basi per l’intervento militare in Libia non potrà poi mettersi a “chiagne” se Gheddafi dovesse bombardare Brindisi, Bari, Sigonella, Aviano o una qualsiasi delle nostre città. Gli abbiamo, di fatto, dichiarato guerra, è legittimato a renderci la pariglia.
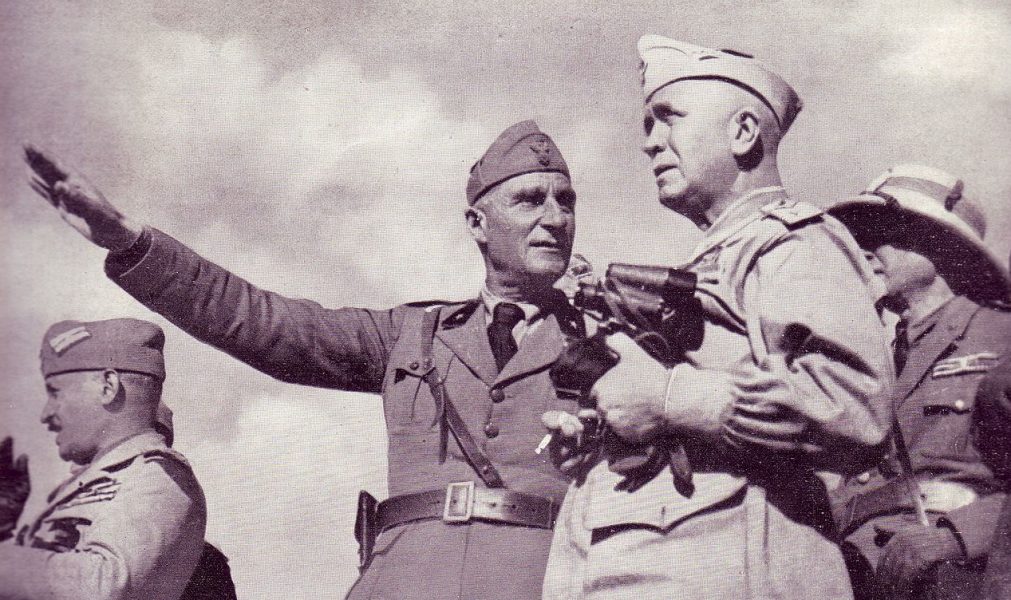
 La storia – liberamente ispirata alla sua infanzia – è quella di Micol Cohen, una bambina ebrea che vive a Tripoli con il padre e la madre, Ruben e Virginia. Personaggi tratteggiati con garbo e senza retorica all’interno di un quadro familiare segnato dalla morte misteriosa di una sorella che Micol non ha mai conosciuto. Quando si scatena la violenza nelle strade anche i Cohen sono costretti a nascondersi nell’appartamento dei nonni materni della piccola, Ghigo e Vera Asti, in attesa di fuggire grazie all’aiuto di un amico arabo che fornirà loro i visti per l’espatrio. Due anni più tardi, nel 1969, il colpo di Stato del Colonnello Gheddafi e la cacciata di re Idris fanno perdere agli ebrei ogni residua speranza: tornare a casa è ormai impossibile. Fra i primi provvedimenti del nuovo regime c’è l’ordine di esproprio dei beni degli italiani, spariscono conti correnti, immobili, terreni, finché dell’antica comunità ebraica della Libia non resterà più alcuna traccia. La drammatica fuga della famiglia Cohen chiude la prima parte del libro, che ricostruisce accuratamente i fatti e il clima politico della Libia di quegli anni. La trama del romanzo riprende poi molti anni anni dopo, raccontando le conseguenze di quello sradicamento. “Ci sono due generi di uomini – scrive Dawan -, quelli che piantano più solide radici altrove e quelli che invece, anche senza averne consapevolezza, si disgregano”. Ruben, il padre di Micol, appartiene alla seconda categoria e in Italia non riuscirà mai a costruirsi una nuova vita. Sarà invece Micol, ormai diventata un avvocato di successo, a tornare finalmente a Tripoli nel 2004 insieme a un gruppo di vecchi esuli ebrei. È quello il momento in cui Gheddafi sta compiendo una serie di gesti di distensione nei confronti dell’Occidente e dell’Italia. Forse esiste la concreta possibilità di ottenere risarcimenti. “Saranno ancora imbevuti di odio?” è la domanda che la protagonista, ormai adulta, si pone iniziando un viaggio nei luoghi della memoria della sua infanzia, in cui scoprirà anche il segreto della morte di sua sorella. Un viaggio che nella realtà l’autrice del libro non ha mai compiuto ma è stata capace di rendere con grande efficacia narrativa, riportando alla luce la memoria di una tragedia sulla quale è caduto il silenzio.
La storia – liberamente ispirata alla sua infanzia – è quella di Micol Cohen, una bambina ebrea che vive a Tripoli con il padre e la madre, Ruben e Virginia. Personaggi tratteggiati con garbo e senza retorica all’interno di un quadro familiare segnato dalla morte misteriosa di una sorella che Micol non ha mai conosciuto. Quando si scatena la violenza nelle strade anche i Cohen sono costretti a nascondersi nell’appartamento dei nonni materni della piccola, Ghigo e Vera Asti, in attesa di fuggire grazie all’aiuto di un amico arabo che fornirà loro i visti per l’espatrio. Due anni più tardi, nel 1969, il colpo di Stato del Colonnello Gheddafi e la cacciata di re Idris fanno perdere agli ebrei ogni residua speranza: tornare a casa è ormai impossibile. Fra i primi provvedimenti del nuovo regime c’è l’ordine di esproprio dei beni degli italiani, spariscono conti correnti, immobili, terreni, finché dell’antica comunità ebraica della Libia non resterà più alcuna traccia. La drammatica fuga della famiglia Cohen chiude la prima parte del libro, che ricostruisce accuratamente i fatti e il clima politico della Libia di quegli anni. La trama del romanzo riprende poi molti anni anni dopo, raccontando le conseguenze di quello sradicamento. “Ci sono due generi di uomini – scrive Dawan -, quelli che piantano più solide radici altrove e quelli che invece, anche senza averne consapevolezza, si disgregano”. Ruben, il padre di Micol, appartiene alla seconda categoria e in Italia non riuscirà mai a costruirsi una nuova vita. Sarà invece Micol, ormai diventata un avvocato di successo, a tornare finalmente a Tripoli nel 2004 insieme a un gruppo di vecchi esuli ebrei. È quello il momento in cui Gheddafi sta compiendo una serie di gesti di distensione nei confronti dell’Occidente e dell’Italia. Forse esiste la concreta possibilità di ottenere risarcimenti. “Saranno ancora imbevuti di odio?” è la domanda che la protagonista, ormai adulta, si pone iniziando un viaggio nei luoghi della memoria della sua infanzia, in cui scoprirà anche il segreto della morte di sua sorella. Un viaggio che nella realtà l’autrice del libro non ha mai compiuto ma è stata capace di rendere con grande efficacia narrativa, riportando alla luce la memoria di una tragedia sulla quale è caduto il silenzio.
